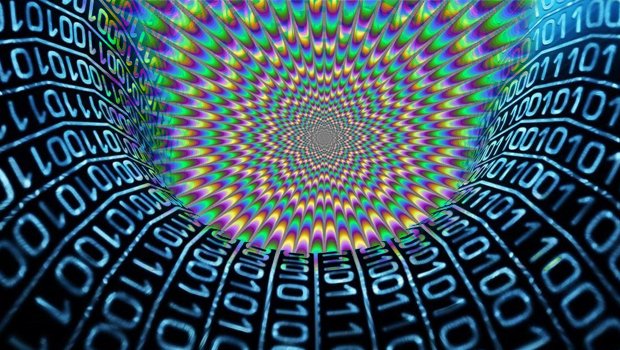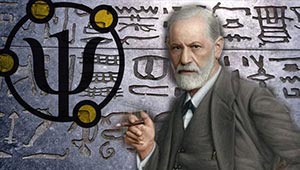La versione originale di questo articolo è stata pubblicata su Infolet il 27 settembre 2017
La scorsa estate, Mark Zuckerberg ha ridefinito la mission di Facebook. Il vecchio motto, “rendere il mondo più aperto e connesso”, è stato sostituito con “dare alle persone il potere di creare comunità e rendere il mondo più unito”. Il cambiamento è la conseguenza, almeno cronologica, di una sorta di viaggio di formazione lungo gli Stati Uniti che Zuckerberg ha intrapreso nel corso dell’anno, a sua detta allo scopo di ampliare le prospettive, come ha riportato il New York Times.
Ecco allora il creatore del Social Network da due miliardi di utenti attivi nel mondo alla guida di un trattore accanto a un contadino del Wisconsin, oppure in raccoglimento tra la comunità afroamericana nella chiesa metodista di Charleston oggetto di attentati razzisti, o ancora assorto insieme alla moglie di fronte ai cartelli stradali di un incrocio in Alabama, in una rivisitazione à la Instagram della mitologia on the road della letteratura e della cinematografia americana. Che sia il preludio di un impegno politico oppure un’operazione dettata dalla necessità di dare nuovo smalto a un’immagine incrinata dalla crisi delle fake news qui poco interessa. Interessa invece notare come questo culto della personalità, modellato sul paradigma dell’innovatore geniale, impersonato da Steve Jobs, e già interpretato in un tour internazionale battezzato Townhall, complementi alla perfezione una narrazione della quale l’applicazione social è la piattaforma tecnologica che si fa opera.
Nell’eliminare dalla missione aziendale senza false ipocrisie l’aggettivo “aperto”, e ponendo l’accento sull’investitura di potere creativo consegnato alle “persone” attraverso la sua creazione, Zuckerberg compie per le interfacce di lettura e scrittura il passaggio definitivo dalla filosofia dell’apertura a quella che Lori Emerson ha definito l’ideologia dello “user friendly” (v. Lori Emerson, Reading writing interfaces: from the digital to the bookbound, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2014, pp. 47-85). Quello che l’iMac e, ancora di più e ancora meglio, l’iPhone hanno fatto per i dispositivi che regolano l’hardware e il software delle nostre vite digitali, Facebook fa per la nostra capacità di leggere e raccontare il mondo: oscurare dietro un design impeccabile, patinato, facile e attraente le strutture e i meccanismi di funzionamento dei programmi e delle storie, accessibili soltanto dai proprietari dell’App Store o dalle logiche algoritmiche del News Feed. Negli anni Settanta, quando le visioni di Ted Nelson sul computer quale “buddy” e mezzo di espressione personale assumevano forma e materia (con il personal dynamic medium di Alan Kay e Adele Goldberg ad esempio, v. Alan Kay e Adele Goldberg, «Personal Dynamic Media», in Wardrip-Fruin Noah e Montfort Nick [a cura di], The New Media Reader, MIT Press, Cambridge, 2003, pp. 393-404), le preoccupazioni riguardo il problema non tanto dell’accesso quanto della literacy inerente il mezzo (e il controllo del mezzo) erano evidenti. Emerson ricorda un editoriale della rivista «Byte» del 1976 in cui Mike Wilber e David Fylstra esprimono la paura che, una volta entrati nella vita quotidiana di casa, i computer lo facciano da “scatole nere” il cui funzionamento intrinseco resti appannaggio dei “sacerdoti”, i veri, intoccabili custodi dei segreti della macchina e del suo codice.
Quaranta anni dopo, Facebook (con Apple e con Google) ha sigillato la scatola del più grande medium personale mai concepito lasciando ai suoi utenti l’illusione del potere di creare contenuti e scrivere storie che in realtà alimentano l’opera-mondo algoritmica e senza fine di Zuckerberg. Processando i metadati, i comportamenti e le interazioni di miliardi di utenti all’interno del giardino chiuso della piattaforma, l’algoritmo compone atti e fatti on the fly e si impone come un narratore onnisciente e totalitario, una macchina di storytelling predittivo che imprigiona vite, biografie e racconti possibili e beneficia gli unici lettori/autori che contano davvero: gli inserzionisti pubblicitari. Perché, a prescindere da tutte le dichiarazioni di intenti, di missioni e di viaggi formativi per capire come mettere insieme le persone e rendere il mondo più unito, quella di Zuckerberg è un’azienda che vende pubblicità, se è vero che i suoi guadagni miliardari arrivano per il 97% dalla vendita di spazi per i banner.
La dittatura narrativa di Facebook cancella la promessa della rete come spazio di narrazioni aperto, collaborativo e partecipato dal basso che era il naturale (e auspicato) sbocco del lavoro di Kay, o di Tim Berners-Lee, tanto per citare il creatore del Web. Come ho scritto nel saggio pubblicato sul numero 17 di «Enthymema», ciò che resta dell’ipertesto oggi è una “rete televisiva”, una piattaforma di broadcasting che privilegia oralità, video e slideshow in modo che con i talk dai palchi dei loro tour o attraverso i loro profili social seguiti da milioni di fan i guru dell’epica digitale e dell’innovazione possano affermarsi come i veri autori di un’epoca neoliberista.
Paolo Sordi, Il narratore algoritmico, in ENTHYMEMA, n. 17, p. 301-313, giugno 2017
La foto di copertina di questo articolo è una rielaborazione di una foto originale di Anthony Quintano, distribuita con licenza CC BY 2.0
Paolo Sordi è responsabile della comunicazione digitale e dei nuovi media dell’Università LUISS Guido Carli di Roma e docente di Progettazione e Realizzazione di Siti Web nel Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata. Si occupa di evoluzione delle strategie di pubblicazione e distribuzione dei contenuti nell’era dei social media, blog, web design. È autore di I Am: Remix Your Web Identity (Cambridge Scholars Publishing, 2015; trad. it. Bloggo con WordPress dunque sono, Dario Flaccovio Editore, 2015) e Progettare per il web (Carocci editore, 2013)..